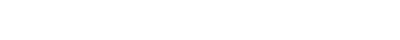Il Torino Film Festival costituisce, a suo modo, un unicum: poco consistente per quanto concerne la sezione del concorso, che generosamente, doverosamente – e forse forzatamente, per la concorrenza di festival più rinomati – ospita solo opere prime, seconde o terze, ma che in ogni modo non spicca in contenuto, si arricchisce sino a strabordare (tanto che il controverso direttore delle ultime quattro edizioni di Venezia, Alberto Barbera, ha parlato, con una certa ineleganza, di “troppi film”) nelle sezioni parallele, tradizionalmente denominate rispettivamente Festa mobile (con un occhio alle novità spiccatamente cosmopolita), After hours (dedicata a un cinema perturbante, per non dire specificamente di matrice horror) e Onde (che tenta, con risultati spesso pregevoli, di esplorare e portare alla luce tutto il sommerso dello sperimentale), sezioni che sovente vanno a visitare, per non dire travalicare, confini, zone liminari, verso ciò che non è già più festival, verso ciò che non è già più cinema – per essere anche, non lo escludiamo, qualcosa di più interessante. E proprio sul concetto di liminalità tra mondi si soffermeranno alcune delle meditazioni ispirate da questa trentatreesima edizione del Festival.
Per cominciare, quel che è emerso da molte proiezioni presentate nelle sezioni parallele del Festival ha indotto nel sottoscritto alcune considerazioni sul linguaggio del cinema. In un film dedicato a Tonino De Bernardi (Des Provinces Lontaines), su cui torneremo anche dopo, parla molto Enrico Ghezzi, che, cambiando idioma da un momento all’altro della frase, medita con lo spettatore sulla maggiore sfida per l’uomo contemporaneo, quella di resistere al dinamismo forsennato della tecnica, a quel bisogno etero-indotto di strappare alla giornata un’ora in più, un’ora migliore, un’ora in un posto migliore: e dunque approdare, per quanto possibile, a una vita in certo senso più monacale, soprattutto più contemplativa; e, ancora, Ghezzi, che riflette sul cinema come ri-essere, ri-mondo, che, in una sorta di delitto perfetto, ha ucciso silenziosamente nel corso di oltre un secolo il mondo di cui si farebbe specchio infedele: il cinema/ri-vita nella vita, anziché la vita nella ri-vita/cinema.
Ma, saremmo allora indotti a pensare, se il cinema è il primo doppio mondo (parallelo, rivissuto, concentrico, come si preferisca) reso sensibile, nel renderlo sensibile, nel rendere sensibile la molteplicità dei mondi, di quest’ultima ha anestetizzato l’Idea. Alcuni cineasti hanno da allora tentato in ogni modo di collocarla nuovamente in evidenza per via intuitiva: o mediante l’agnizione di analogie tattili, come Maya Deren, l’eccentrica artista russa che, negli anni ’40, ancora giovanissima, per studiare tale analogia come prima intuizione di un’interconnessione fra enti tra loro divisi sino a rendersi invisibili l’un l’altro, si dedicò allo studio della filosofia Voodoo mentre realizzava alcuni dei più avanguardistici cortometraggi di sempre; o invece per specularità, come ha fatto più recentemente Raul Ruiz, che ha reso i mondi doppi, tripli, quadrupli, labirinticamente moltiplicantisi, sino infine a suggerire l’assenza di un loro principio o di una loro fine noti.
Alcuni ospiti illustri del Torino Film Festival si sono esibiti in questa esplorazione di universi paralleli/possibili. Il giapponese Sion Sono, onorato di una rassegna nel 2011 e da allora quasi ogni anno presente con i nuovi film, in questa edizione ne ha presentati tre, due almeno dei quali hanno confermato una già individuata e neanche, forse, riuscitissima, deriva pop, da parte di un cineasta fino a meno di un decennio fa profondamente sperimentale. In Real Oni Gokko / Tag esplora, secondo una certa chiave horror, il passaggio tra mondi, attraverso una serie di camuffate iniziazioni, per cercare di spiegare, senza spiegarsi, la teoria secondo cui una sola scelta autenticamente cosciente possa alterare il corso di una determinata linea temporale.
Il geniale canadese Guy Maddin con The forbidden room centra invece una riproposizione fastosa del suo universo bizzarro, lisergico e archetipico. Sul filo di una sottile e leggermente autoreferenziale ironia, fa precipitare, con barocca voluttà, un mondo dentro l’altro, mescolando paesaggi onirici, sensuali evocazioni, atmosfere misteriche, storie di strani personaggi – pare cruciale l’episodio del diplomatico innamorato del Dio Giano che, bifronte, è signore dei confini, delle soglie, dei cancelli, delle aree di passaggio tra una realtà e l’altra, che pur si osservano, forse si riflettono.
Tonino De Bernardi è ospite fisso del festival, quasi abbia un contratto a vita. Tra parentesi, stona infatti un tantino quando si presenta come il più indipendente degli indipendenti, l’anticonvenzionale che non ha ormai quasi più un seguito: il suo è comunque un privilegio di cui pochi sono onorati, ma che certo si può convenire accordato verso la fine di una carriera, come la sua, così lunga e pregna di stimoli. Il film Des Provinces Lontaines, però, non è diretto da lui, forse perché non ne ha diretti quest’anno, ammettendo lui stesso di essersi perso tra troppi progetti e di avere difficoltà a fare ordine e passare alla realizzazione di ciascuno – gli facciamo comunque i migliori auguri; il film è su di lui. Comunque, non parla lui solo, parlano l’amico Enrico Ghezzi, delle cui meditazioni abbiamo accennato in apertura, parla il genero, e brevemente appare anche Massimo Bacigalupo, amico ed ex collega (ai tempi dell’underground, giacché i due furono tra i maggiori autori italiani dell’underground, finché durò), oltre che stimatissimo accademico che non gira più nulla dal 1975 essendosi però dato alla videoarte. Anche De Bernardi, comunque, da regista, ha sempre particolarmente amato cimentarsi nei labirinti, nei giochi a incastri: senza andare indietro sino all’epopea dell’underground, lo sottolineano anche le sue ultime fatiche, tra cui, degna di particolare interesse, e, purtroppo, mi pare di ricordare che egli mi disse una volta, assolutamente mai distribuita, è, a parere di chi scrive, La Passione di San Giovanni.
Un altro autore che, a partire da una rassegna dedicatagli nel 2011, non ha mai mancato l’appuntamento del Festival ogni qual volta gli fosse possibile, è il surrealista Eugene Green. Ha fregiato questa edizione della prima di un suo documentario, Faire la parole, dedicato ai Baschi, popolazione che rivendica la propria identità e autonomia a partire dalla (scientificamente provata) irriducibile diversità del loro mondo mitologico tradizionale e soprattutto della loro lingua, risalente ad antichità plurimillenarie e da allora rimasta intatta, priva di qualsiasi parentela con tutti gli altri idiomi europei evidentemente sviluppatisi o importati (durante alcune grandi migrazioni) in ere successive. Egli medita così su come, costruendo, proprio basicamente, la parola, e così strutturando un linguaggio, si costruisca l’identità di un soggetto, anche politico. Naturalmente è questo il tempo in cui molti si propongono di realizzare documentari d’autore, e quel tratto un po’ naif che poteva, nei film surrealisti di Green, contribuire a forgiarne parte della magia, trasposto in un contesto come quello documentaristico, nel quale raggiungere un livello di sospensione dell’incredulità è decisamente più problematico, induce effetti stridenti.
Ma naturalmente non solo questo è il tempo in cui molti si sono proposti di realizzare documentari d’autore. Méditerranée, datato 1963, di Jean-Daniel Pollet e Volker Schlöndorff, è una lunga sequenza di immagini che rappresentano paesaggi, scene di vita, monumenti antichi e moderni, dell’intera area mediterranea, accompagnate da un enigmatico flusso di coscienza. Recentemente Godard aveva riutilizzato, senza permesso, alcuni passaggi di quella vecchia pellicola nel suo Film socialisme. Siccome Pollet non voleva andare in causa con Godard, ha pensato di girare un documentario, poi intitolato JDP/JLG (le iniziali dei due), in cui gli domanda di Méditerranée: e la risposta è interessante, anche dal momento che il tema di una delle retrospettive del festival di quest’anno riguardava la distopia, ma, mentre la retrospettiva contemplava film finzionalmente distopici girati magari cinquant’anni fa e oltre, qui Godard ci parla di una sua visione filosoficamente distopica, e comincia col dire che Méditerranée evoca il modo in cui saremmo morti in quanto cultura classica: ma in cosa sarebbe consistita questa morte? Godard parla di un “partito preso degli uomini” ed un “partito preso delle cose”: dietro la macchina da presa c’è l’uomo, il suo sguardo; davanti le cose. Il rapporto tra le due estremità funzionali della ripresa si configura, egli sostiene, come etico, e moriamo allorché questo rapporto non è più sorretto da una consapevolezza: così si verifica la reificazione dell’immagine-cosa e l’assolutizzazione dello sguardo egoico. Viene con ciò alla luce quella che è stata l’ambizione di Godard da sempre, almeno da quando si distanziò dai colleghi della Nouvelle Vague, quella di destrutturare il cinema per sondarne un senso più originario – destrutturare la trama, destrutturare anche il rapporto tra immagine e suono – senza che egli peraltro sia forse mai giunto a un punto ultimo e definitivo della sua ricerca, appassionante tuttavia per questo.
Chiariamo per un momento che l’uso del linguaggio non asserisce alcuna oggettivazione delle cose nominate. In altre parole, solo un utilizzo complessivamente molto ristretto del linguaggio serve a statuire che un angolo è qualcosa di intrinsecamente (non per i suoi usi, ecc.) diverso da un muro piatto. La maggior parte degli usi del linguaggio tende ad assorbire in categorie (ad esempio, spazialità, temporalità, mondanità-umanità, funzionalità, ecc.) delle relazionalità (di interrogati in quanto ci-sono). Ipotizziamo di dire che un gruppo di persone si riunisce in certi posti (per dire: delle logge) per fare certe cose (per dire: studiare la Gnosi), ma questa è la strutturazione in termini narrativi, è il “montaggio” (stiamo per tornare al cinema) che il linguaggio ci consente di fare di qualcosa che accade, che accade comunque. Potremmo riferire quel che accade in modi diversi, alieni potrebbero sopraggiungere e dire di quel che accade in modo diverso dal nostro, ma ugualmente vero, essendo vero l’accadimento di cui si dice (o di cui si filma). Un cinema non narrativo, o finanche privato dalla necessità di un rapporto rigoroso tra immagini, suoni e parole, chiarisce proprio questo: che qualcosa accade che lo si narri, o lo si ponga, in un modo o in altro. E dunque, e non mi pare poco, ciò implica una moltiplicazione dei linguaggi senza che se ne sia prigionieri, e, ulteriormente, una moltiplicazione dei mondi senza che se ne sia incatenati. Ecco allora che quel “di più” che si cerca già preesiste in noi, prima che scegliamo una narrazione atta a vocare il reale, e vi ci incateniamo. Viceversa, evitare di incatenarci a una narrazione delle cose può portarci a differenziare continuamente il mondo, anzichè ripeterlo: forse, a cogliere una vastità. Questo svela il cinema, in particolar modo un cinema della narrazione debole o della rinuncia alla narrazione.
Si menzioneranno ora in una rapida panoramica a volo d’uccello altre visioni di un certo interesse che il Festival ha proposto: una striminzita retrospettiva su Orson Welles, di cui ricorre il centennale dalla nascita, con Quarto potere, Rapporto confidenziale e L’infernale Quinlan, tutti capolavori, ma troppo visti, rispetto allo sconfinato non-visto del gigante del cinema moderno; una commemorazione di Chantal Akerman, la grande regista sperimentale belga, deceduta prematuramente pochi mesi or sono, con il cortometraggio Lettre d’un cinéaste e il mediometraggio Chantal Akerman par Chantal Akerman; il restauro, ad opera della Cineteca di Bologna, di Sayat Nova, la pellicola armena che nel 1968 sconvolse l’Unione Sovietica e il mondo per il suo stile irripetibile – forse il film più atemporale mai girato, un’esperienza visiva sconcertante ed abbagliante al tempo stesso –, ispirata ad alcuni componimenti dell’omonimo poeta del Settecento armeno, diretta da Sergej Paranajov; e poi c’è la tematica greca, e se in proposito Ben Rivers ci regala, con A distant episode, un cortometraggio di una visionarietà abbacinante, come a lui e a pochi può riuscire, Symptoma di Angelos Frantzis conferma una tendenza, già ravvisata nel cinema ellenico, di chiudersi in una sorta di ostica autoreferenzialità metacinematografica, sintomo forse di un senso diffuso di incomunicabilità; Under electric clouds di Alexey German figlio, già in Berlinale, medita, tra tempi dilatati e paesaggi dell’interiorità, sulla storia (e lo spazio) russi, tingendosi di un senso di spaesamento, tra un passato ambivalente e un futuro precario; High-Rise di Ben Wheatley corona un sogno coltivato per un trentennio dal celebre produttore indipendente Jeremy Thomas, ossia la trasposizione di Condominio di J. G. Ballard – un film nel quale la vicenda del grattacielo dove gli inquilini sono disposti più o meno in basso o in alto a seconda della loro posizione sociale, scatenando violenti conflitti tra piani, sotto lo sguardo ironico dell’architetto Royal, che occupa l’ultimo piano, si tinge, come nel libro, di molteplici valenze politiche, sociologiche, antropologiche, ma che l’emergente regista inglese Wheatley rende forse più tramite episodi di frantumazione fisica, piuttosto che con profonde suggestioni psicologiche; Miguel Gomes, con As mil e uma noites, tenta di trasporre nella problematica attualità del Portogallo post-austerity l’immortale vicenda di Sheherazade.
(Articolo del 4 dicembre 2015)